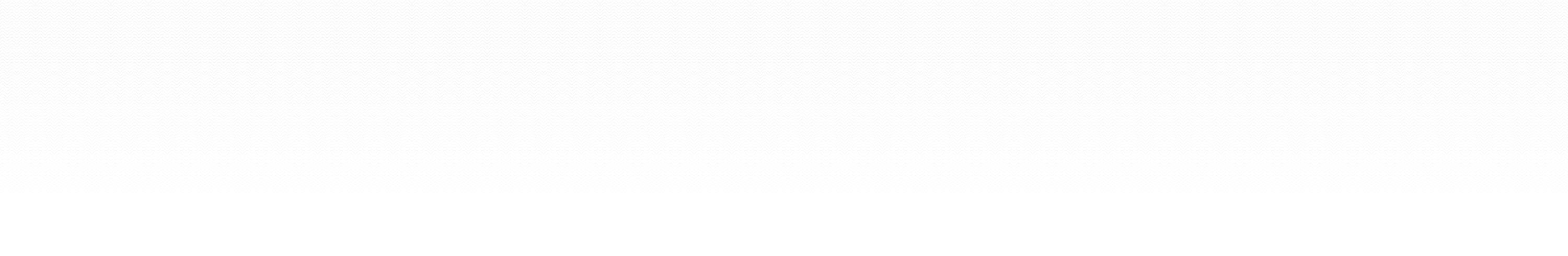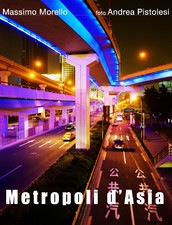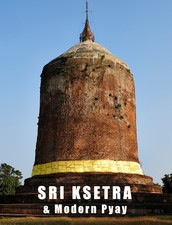Storie
La Storia di Essere Tempo
17/10/13 13:47
Il gatto di casa si chiama Schrödinger. E’ lui la chiave di tutto. Nel senso che tutto può essere, al tempo stesso, sia essere sia non-essere. Il nome del gatto richiama il paradosso del fisico Erwin Schrödinger, uno di quegli esperimenti mentali tanto affascinanti quanto poco comprensibili indotti dalla meccanica quantistica.
Schrödinger è un personaggio di Una storia per l’essere tempo, ultimo romanzo di Ruth Ozeki.
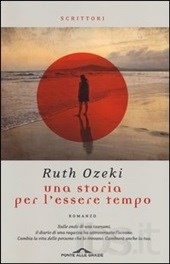
“Un Essere Tempo è qualcuno che vive nel tempo. Il che significa tu e io e chiunque di noi è, era oppure sarà”, chiarisce nelle prime righe la scrittrice e monaca zen. E anche questa può apparire un’affermazione quantica: il tempo può essere sperimentato solo come un insieme di relazioni interdipendenti. Tesi sostenuta circa ottocento anni fa da Dogen Zenji (1200-1253) uno dei maggiori pensatori del Giappone e dei più grandi maestri di buddhismo zen, nel suo saggio Essere tempo. Maestro che ha ispirato la stessa Ozeki, come lei ha dichiarato in un’intervista.
Visto così, il libro può apparire l’ennesima storia post-new-age. In realtà – non a caso era tra i finalisti del prestigioso Man Booker Prize 2013 – è un romanzo complesso, che intreccia mistery e meditazione, storia e cronaca, diversi livelli spazio-temporali.
A mio giudizio è splendido.
A parte il mio giudizio, si presta a diverse considerazioni. Sullo scrivere come “forma di preghiera”. «Non stai pregando un Dio, ma stai evocando qualcuno che ti ascolti» ha detto la Ozeki, paragonando lo scrittore a chi “sente le voci”. «C’è sempre stato chi sente delle voci. A volte sono chiamati sciamani. Altre pazzi. E certe volte romanzieri».
Schrödinger, il fisico e il gatto, il monaco, lo sciamano, lo scrittore e tutti i personaggi di questo romanzo, a loro volta, dimostrano come sia possibile scrivere un romanzo filosofico. Il che è stato ed è messo in dubbio da molti. Secondo una visione molto occidentale e limitata, infatti, appartengono a due mondi diversi, richiedono modi di pensare e scrivere diversi.
“Una storia per l’essere tempo”, quindi, è l’ennesima opera delle Avventure della verità, quelle che compongono il racconto del millenario corpo a corpo tra arte e filosofia.
Il racconto, il “rècit” su Les Aventures de la vérité, è ancora in mostra alla Fondazione Maeght di Saint Paul-de Vence. Curata da Bernard-Henri Lévy, materializza, come ha scritto il filosofo-avventuriero, “il progetto un po’ folle di raccontare assieme, incrociandole, la storia della filosofia e quella della pittura”. Ciò che dice della pittura, infatti, si può ben applicare alla letteratura: «Credo davvero che la sua prima vocazione, il primo ruolo, è pensare, e farci pensare, il mondo».
 “Caverne de Platon”, di Huang Yong Ping, da “Les Aventures de la Vérité”
“Caverne de Platon”, di Huang Yong Ping, da “Les Aventures de la Vérité”
Tutto ciò non può essere facile, come oggi vogliono farci credere i profeti del pensiero incolto. E ancora una volta la chiave di tutto è il gatto di Schrödinger. Bisogna scegliere se vivere dentro una scatola restando per sempre intrappolati nel paradosso oppure aprire la scatola. Per cominciare apriamo la borsetta di Hello Kitty che contiene la storia di essere tempo.
Schrödinger è un personaggio di Una storia per l’essere tempo, ultimo romanzo di Ruth Ozeki.
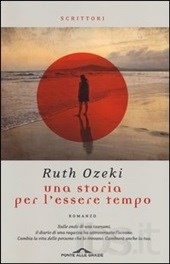
“Un Essere Tempo è qualcuno che vive nel tempo. Il che significa tu e io e chiunque di noi è, era oppure sarà”, chiarisce nelle prime righe la scrittrice e monaca zen. E anche questa può apparire un’affermazione quantica: il tempo può essere sperimentato solo come un insieme di relazioni interdipendenti. Tesi sostenuta circa ottocento anni fa da Dogen Zenji (1200-1253) uno dei maggiori pensatori del Giappone e dei più grandi maestri di buddhismo zen, nel suo saggio Essere tempo. Maestro che ha ispirato la stessa Ozeki, come lei ha dichiarato in un’intervista.
Visto così, il libro può apparire l’ennesima storia post-new-age. In realtà – non a caso era tra i finalisti del prestigioso Man Booker Prize 2013 – è un romanzo complesso, che intreccia mistery e meditazione, storia e cronaca, diversi livelli spazio-temporali.
A mio giudizio è splendido.
A parte il mio giudizio, si presta a diverse considerazioni. Sullo scrivere come “forma di preghiera”. «Non stai pregando un Dio, ma stai evocando qualcuno che ti ascolti» ha detto la Ozeki, paragonando lo scrittore a chi “sente le voci”. «C’è sempre stato chi sente delle voci. A volte sono chiamati sciamani. Altre pazzi. E certe volte romanzieri».
Schrödinger, il fisico e il gatto, il monaco, lo sciamano, lo scrittore e tutti i personaggi di questo romanzo, a loro volta, dimostrano come sia possibile scrivere un romanzo filosofico. Il che è stato ed è messo in dubbio da molti. Secondo una visione molto occidentale e limitata, infatti, appartengono a due mondi diversi, richiedono modi di pensare e scrivere diversi.
“Una storia per l’essere tempo”, quindi, è l’ennesima opera delle Avventure della verità, quelle che compongono il racconto del millenario corpo a corpo tra arte e filosofia.
Il racconto, il “rècit” su Les Aventures de la vérité, è ancora in mostra alla Fondazione Maeght di Saint Paul-de Vence. Curata da Bernard-Henri Lévy, materializza, come ha scritto il filosofo-avventuriero, “il progetto un po’ folle di raccontare assieme, incrociandole, la storia della filosofia e quella della pittura”. Ciò che dice della pittura, infatti, si può ben applicare alla letteratura: «Credo davvero che la sua prima vocazione, il primo ruolo, è pensare, e farci pensare, il mondo».
 “Caverne de Platon”, di Huang Yong Ping, da “Les Aventures de la Vérité”
“Caverne de Platon”, di Huang Yong Ping, da “Les Aventures de la Vérité”Tutto ciò non può essere facile, come oggi vogliono farci credere i profeti del pensiero incolto. E ancora una volta la chiave di tutto è il gatto di Schrödinger. Bisogna scegliere se vivere dentro una scatola restando per sempre intrappolati nel paradosso oppure aprire la scatola. Per cominciare apriamo la borsetta di Hello Kitty che contiene la storia di essere tempo.
A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki -- Official Book Trailer from Viking Books on Vimeo.
|
Che il panda mi aiuti
27/06/12 11:56
Una storia di scatole cinesi. Bisognerebbe cercare le scatole. Poi mettere assieme quel che s’è trovato. Alla fine, forse, apparirebbe una gran bella storia sull’Asia. Di ieri e domani. Il presente, si sa, non esiste, e in Asia è ancor più liquido.
Per ora – ma quale ora ? – ne trovate una traccia nella sezione Storie: La donna drago, il taoista e altri demoni.
Per il seguito, chissà. A Kep vorrei comunque tornarci, a Phnom Penh devo andare per il summit Asean. Riguardo a Chongqing c’è un nuovo volo Air Asia da Bangkok e ne approfitterei per vedere lo zoo della città con la sua Panda room.
I panda, quelli sì, interessano.

Per ora – ma quale ora ? – ne trovate una traccia nella sezione Storie: La donna drago, il taoista e altri demoni.
Per il seguito, chissà. A Kep vorrei comunque tornarci, a Phnom Penh devo andare per il summit Asean. Riguardo a Chongqing c’è un nuovo volo Air Asia da Bangkok e ne approfitterei per vedere lo zoo della città con la sua Panda room.
I panda, quelli sì, interessano.

La morte altrove
21/06/12 10:24
Vacanza, Altrove. Due parole che esprimono due miti. Spesso indissolubilmente legate. La vacanza è altrove. L’altrove è vacanza, in quanto luogo dove ci si distacca (o si crede di poterlo fare) dai pensieri, dalle ansie, dai problemi quotidiani. Accade però che una di queste parole assuma un significato inquietante, specie nella cultura italiana. E’ Altrove. Il luogo dove tutto è diverso, sconosciuto, potenzialmente ostile, dove anche il cibo nasconde insidie sottili. Ecco allora che la vacanza in un qualsiasi altrove, da sogno si trasforma in incubo. Figurarsi quando l’altrove è la scena di un crimine.
Questo il senso del testo pubblicato nella sezione Storie. S’intitola Morte nei luoghi remoti e fa parte di un libro appena uscito: Faking It in Bangkok (Finzioni a Bangkok). Il libro raccoglie una serie di articoli e post di Christopher G. Moore, scrittore canadese che vive in Thailandia dal 1988, noto soprattutto per i suoi racconti e romanzi, gialli e neri, ambientati in sud-est asiatico.
Quello (o questo, per Moore come per chi scrive) è l’immagine matrice dell’Altrove con tutti i suoi esotismi umani, naturali, culturali, veri o presunti. Là/qui, ogni trama si carica di mistero, la realtà si fa romanzesca, tanto per usare un altro luogo comune. E così, paradossalmente, si sdrammatizza, diviene ulteriore elemento di fascino, per quanto morboso, che alimenta ancora il mito dell’Altrove. In un circolo, letteralmente, vizioso.
Intanto, a confermare ciò che scrive Moore, e degno di un suo thriller, ecco il caso delle due sorelle canadesi trovate morte nella loro stanza d’albergo a Phi Phi Island, uno dei luoghi simbolo della vacanza esotica, là dove è stato girato il film “The Beach” con Leonardo Di Caprio (film, anch’esso, che materializza i sogni e gl’incubi della vacanza esotica).
Le due sorelle non mostrano segni di violenza, né pare siano state uccise. Stando alle prime informazioni sembra siano morte per avvelenamento, ma le cause sono ancora tutte da chiarire. Come quelle all’origine della morte di due altre turiste, un’americana e una canadese, avvenuta nel 2009 nella stessa isola nello stesso modo. Per le indagini è già stata contattata la dottoressa Pornthip Rojanasunand, direttrice dell’istituto di patologia forense Thailandese, incarnazione asiatica di Kay Scarpetta, il personaggio dell'autrice di thriller Patricia Cornwell. Il che, più che tranquillizzare, dà qualche brivido in più. Che col caldo ci sta anche bene.
 Et in Arcadia ego, un quadro del Guercino (1591-1668). La frase alla base del dipinto può tradursi letteralmente: "Anche in Arcadia io”. Interpretabile in molti modi, in questo caso ci richiama all’onnipresenza della morte nello spazio e nel tempo. Sempre e ovunque, anche nei luoghi dell’Ideale come l’Arcadia.
Et in Arcadia ego, un quadro del Guercino (1591-1668). La frase alla base del dipinto può tradursi letteralmente: "Anche in Arcadia io”. Interpretabile in molti modi, in questo caso ci richiama all’onnipresenza della morte nello spazio e nel tempo. Sempre e ovunque, anche nei luoghi dell’Ideale come l’Arcadia.
Questo il senso del testo pubblicato nella sezione Storie. S’intitola Morte nei luoghi remoti e fa parte di un libro appena uscito: Faking It in Bangkok (Finzioni a Bangkok). Il libro raccoglie una serie di articoli e post di Christopher G. Moore, scrittore canadese che vive in Thailandia dal 1988, noto soprattutto per i suoi racconti e romanzi, gialli e neri, ambientati in sud-est asiatico.
Quello (o questo, per Moore come per chi scrive) è l’immagine matrice dell’Altrove con tutti i suoi esotismi umani, naturali, culturali, veri o presunti. Là/qui, ogni trama si carica di mistero, la realtà si fa romanzesca, tanto per usare un altro luogo comune. E così, paradossalmente, si sdrammatizza, diviene ulteriore elemento di fascino, per quanto morboso, che alimenta ancora il mito dell’Altrove. In un circolo, letteralmente, vizioso.
Intanto, a confermare ciò che scrive Moore, e degno di un suo thriller, ecco il caso delle due sorelle canadesi trovate morte nella loro stanza d’albergo a Phi Phi Island, uno dei luoghi simbolo della vacanza esotica, là dove è stato girato il film “The Beach” con Leonardo Di Caprio (film, anch’esso, che materializza i sogni e gl’incubi della vacanza esotica).
Le due sorelle non mostrano segni di violenza, né pare siano state uccise. Stando alle prime informazioni sembra siano morte per avvelenamento, ma le cause sono ancora tutte da chiarire. Come quelle all’origine della morte di due altre turiste, un’americana e una canadese, avvenuta nel 2009 nella stessa isola nello stesso modo. Per le indagini è già stata contattata la dottoressa Pornthip Rojanasunand, direttrice dell’istituto di patologia forense Thailandese, incarnazione asiatica di Kay Scarpetta, il personaggio dell'autrice di thriller Patricia Cornwell. Il che, più che tranquillizzare, dà qualche brivido in più. Che col caldo ci sta anche bene.
 Et in Arcadia ego, un quadro del Guercino (1591-1668). La frase alla base del dipinto può tradursi letteralmente: "Anche in Arcadia io”. Interpretabile in molti modi, in questo caso ci richiama all’onnipresenza della morte nello spazio e nel tempo. Sempre e ovunque, anche nei luoghi dell’Ideale come l’Arcadia.
Et in Arcadia ego, un quadro del Guercino (1591-1668). La frase alla base del dipinto può tradursi letteralmente: "Anche in Arcadia io”. Interpretabile in molti modi, in questo caso ci richiama all’onnipresenza della morte nello spazio e nel tempo. Sempre e ovunque, anche nei luoghi dell’Ideale come l’Arcadia. Sul filo del rasoio
18/05/12 05:21
“Difficile è il passo sul filo tagliente di un rasoio: così i saggi dicono che è ardua la via della salvezza”. E’ un passo della Katha Upanishad, una delle più antiche scritture della religione hindu, detta anche “La Morte come Maestra”. E’ citato in apertura del romanzo di W. Somerset Maugham Il filo del rasoio.
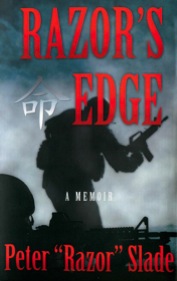 Stesso titolo e analogie esistenziali in un libro appena uscito: Razor’s Edge, autobiografia di Peter “Razor” Slade. Un uomo con molti interrogativi. «Sono un mercenario? Sono un consulente per la sicurezza? Sono un imprenditore militare privato? Sono un free lance o, come certi dicono oggi, sono un deniable, un uomo che viene sconfessato? Sono un po’ di tutto questo, forse?».
Stesso titolo e analogie esistenziali in un libro appena uscito: Razor’s Edge, autobiografia di Peter “Razor” Slade. Un uomo con molti interrogativi. «Sono un mercenario? Sono un consulente per la sicurezza? Sono un imprenditore militare privato? Sono un free lance o, come certi dicono oggi, sono un deniable, un uomo che viene sconfessato? Sono un po’ di tutto questo, forse?».
Slade, australiano, ha combattuto la sua prima guerra in Vietnam, dove arriva nel ’68 e ci resta sino al ’70. Da allora, salvo rari momenti di quiete, non ha mai smesso di combattere, in un modo o nell’altro. Nel 2005, a 57 anni, quando molti pensano alla pensione, è partito per l’Iraq. Lo tsunami che aveva colpito l’isola di Phuket, in Thailandia, dove viveva e vive con la moglie Nen, lo aveva rovinato. Non poteva far altro che firmare come security contractor per guidare i convogli che attraversavano il paese. In sette anni ha compiuto mille missioni. Poi ha deciso che era arrivato il momento di tornare a casa. Non che si fosse stancato, aveva litigato.
È contento di vedere che il suo libro abbia suscitato interesse. Più ancora che ci sia qualcuno che vada a trovarlo per ascoltarlo. Forse perché per troppo tempo è vissuto nell’ombra della “deniability”, un’ossessione per lui. E’ un termine ambiguo, rappresenta un concetto che lo è ancor di più: un potente giocatore manovra le sue pedine senza mai apparire, tanto pronto a sacrificarle quanto abile nell’attribuire ad altri le mosse sbagliate.
Slade materializza l’immagine del contractor nel fisico, per come parla, si presenta, in particolari come lo Zippo decorato da emblemi militari. Ma infrange anche molti stereotipi. Proprio per il suo voler uscire dall’ombra della deniability, ripete la necessità di regole. Paradossalmente, ma non tanto, delinea l’immagine del contractor ideale descritto da Laura Dickinson del “Center for Law and Global Affairs”. Nel saggio Outsourcing War and Peace: Preserving Public Values in a World of Privatized Foreign Affairs, la Dickinson cerca di definire nuove regole affinché i contractor si adeguino ai valori condivisi di diritti umani, rispetto dei principi di democrazia, trasparenza.
Ma soprattutto Razor esce da quelli che lui chiama “i suoi silenzi”. Parla. Parla moltissimo, quasi ininterrottamente, le parole che inseguono «mille pensieri di continuo».
Così, almeno per me, lo Starbucks del centro commerciale Jonceylon di Phuket, diventa come il cafè del porto di Tolone descritto dall’Io narrante del romanzo di Maugham: “fa l’effetto di un capolinea dove convergono tutte le vie del vasto mondo”. E come in quel romanzo il narratore entra nella trama, così, ascoltando Razor, scorrono immagini di luoghi che conosco, scene di cui ho visto tracce e macerie, storie di cui ho incontrato altri reduci. Il senso delle sue domande potrei farlo mio: in fondo la differenza tra un free lance che interpreta le storie e uno che le racconta sta anch’essa sul filo di un rasoio. In entrambi i casi si patiscono simili “danni collaterali”, come li chiama Razor: problemi con gli amici, la famiglia. Allo stesso modo ti senti in una “comfort zone” quando ti trovi in una situazione che ti coinvolge profondamente.
«La guerra è una droga. Non per il combattimento, ma per l’ambiente» dice Razor. E non si riferisce solo all’“hostile environment”. Pensa all’amicizia che la guerra crea, a quella che in Australia chiamano “mateship”, la fratellanza, da mate «che non è solo un amico, è uno a cui affidi la vita». Come scrisse Hemingway, la guerra è male, ma c’è qualcosa nella guerra che, oltre al peggio, tira fuori anche il meglio degli uomini.
Razor s’inserisce in una cultura anch’essa deniable, negata, dichiarata falsa, scorretta. Quella analizzato dal filosofo James Hillman in Un terribile amore per la guerra, dove, frantumando la retorica politicamente corretta, ci spinge dentro “lo stato marziale dell’anima”. E’ quella raccontato da Sebastian Junger in War, cronaca e riflessione della sua esperienza da embedded in Afghanistan. Da quell’esperienza Junger e il fotografo Tim Hetherington (ucciso nel 2011 in Libia) hanno anche realizzato il documentario Restrepo. Libro e documentario sono una meditazione sulla guerra come condizione senza tempo dell’uomo. La guerra è ciò che Junger definisce “la difesa della tribù”, un istinto ancestrale. “La difesa del gruppo può rivelarsi così istintiva, può dare una tale dipendenza, che diviene la ragione stessa per cui il gruppo esiste…I ragazzi non combattono per la libertà o per patriottismo. Combattono perché sanno che possono essere uccisi”. Istinto che riappare nel saggio What It Is Like to Go to War di Karl Marlantes, che ha combattuto in Vietnam e ha già raccontato la sua esperienza in un romanzo divenuto bestseller: Matterhorn (qui in una recensione di Sebastian Junger).
Ma queste sono considerazioni che verranno dopo, quando cercherai di affermare le negazioni, esorcizzare le paure, sciogliere i dubbi. «Chi sono i buoni e chi sono i cattivi?» è la domanda che Razor ripete spesso e ti contagia.
Ascoltando Razor, d’un tratto, come il narratore del libro di Maugham, prendi le distanze, sei messo di fronte alle differenze. Come quando, indicando tante foto nel suo libro, Razor ripete: «Lui è morto, lui è morto, lui è morto, lui è morto…lui è morto…». Poche le morti per malattia. Un suicidio.
Quel filo di rasoio s’interseca sottilmente con molti altri, diventa una ragnatela tagliente. E senti il bisbiglio registrato del Colonnello Kurtz di Apocalypse Now. “Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere”.
Quel senso d’angoscia si scioglie a casa di Razor, nel nord di Phuket, in un gruppo di villette circondate da un piccolo giardino ombreggiato dagli alberi che sembra un quartiere di una cittadina dell’outback australiano. Respiri un’atmosfera quieta, mangiando un mango fresco, bevendo un succo di frutta preparato da una sorridente Nen, finalmente serena. La presenza di Razor l’avverti solo nella stanzetta dove lavora e conserva i suoi cimeli. Uno dei più preziosi è l’amaca di un soldato vietcong, ripiegata con cura assieme a molte bandiere. Emanano un leggero odore di naftalina.
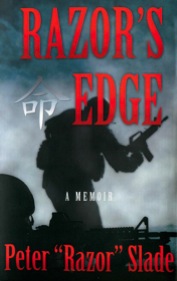 Stesso titolo e analogie esistenziali in un libro appena uscito: Razor’s Edge, autobiografia di Peter “Razor” Slade. Un uomo con molti interrogativi. «Sono un mercenario? Sono un consulente per la sicurezza? Sono un imprenditore militare privato? Sono un free lance o, come certi dicono oggi, sono un deniable, un uomo che viene sconfessato? Sono un po’ di tutto questo, forse?».
Stesso titolo e analogie esistenziali in un libro appena uscito: Razor’s Edge, autobiografia di Peter “Razor” Slade. Un uomo con molti interrogativi. «Sono un mercenario? Sono un consulente per la sicurezza? Sono un imprenditore militare privato? Sono un free lance o, come certi dicono oggi, sono un deniable, un uomo che viene sconfessato? Sono un po’ di tutto questo, forse?». Slade, australiano, ha combattuto la sua prima guerra in Vietnam, dove arriva nel ’68 e ci resta sino al ’70. Da allora, salvo rari momenti di quiete, non ha mai smesso di combattere, in un modo o nell’altro. Nel 2005, a 57 anni, quando molti pensano alla pensione, è partito per l’Iraq. Lo tsunami che aveva colpito l’isola di Phuket, in Thailandia, dove viveva e vive con la moglie Nen, lo aveva rovinato. Non poteva far altro che firmare come security contractor per guidare i convogli che attraversavano il paese. In sette anni ha compiuto mille missioni. Poi ha deciso che era arrivato il momento di tornare a casa. Non che si fosse stancato, aveva litigato.
È contento di vedere che il suo libro abbia suscitato interesse. Più ancora che ci sia qualcuno che vada a trovarlo per ascoltarlo. Forse perché per troppo tempo è vissuto nell’ombra della “deniability”, un’ossessione per lui. E’ un termine ambiguo, rappresenta un concetto che lo è ancor di più: un potente giocatore manovra le sue pedine senza mai apparire, tanto pronto a sacrificarle quanto abile nell’attribuire ad altri le mosse sbagliate.
Slade materializza l’immagine del contractor nel fisico, per come parla, si presenta, in particolari come lo Zippo decorato da emblemi militari. Ma infrange anche molti stereotipi. Proprio per il suo voler uscire dall’ombra della deniability, ripete la necessità di regole. Paradossalmente, ma non tanto, delinea l’immagine del contractor ideale descritto da Laura Dickinson del “Center for Law and Global Affairs”. Nel saggio Outsourcing War and Peace: Preserving Public Values in a World of Privatized Foreign Affairs, la Dickinson cerca di definire nuove regole affinché i contractor si adeguino ai valori condivisi di diritti umani, rispetto dei principi di democrazia, trasparenza.
Ma soprattutto Razor esce da quelli che lui chiama “i suoi silenzi”. Parla. Parla moltissimo, quasi ininterrottamente, le parole che inseguono «mille pensieri di continuo».
Così, almeno per me, lo Starbucks del centro commerciale Jonceylon di Phuket, diventa come il cafè del porto di Tolone descritto dall’Io narrante del romanzo di Maugham: “fa l’effetto di un capolinea dove convergono tutte le vie del vasto mondo”. E come in quel romanzo il narratore entra nella trama, così, ascoltando Razor, scorrono immagini di luoghi che conosco, scene di cui ho visto tracce e macerie, storie di cui ho incontrato altri reduci. Il senso delle sue domande potrei farlo mio: in fondo la differenza tra un free lance che interpreta le storie e uno che le racconta sta anch’essa sul filo di un rasoio. In entrambi i casi si patiscono simili “danni collaterali”, come li chiama Razor: problemi con gli amici, la famiglia. Allo stesso modo ti senti in una “comfort zone” quando ti trovi in una situazione che ti coinvolge profondamente.
«La guerra è una droga. Non per il combattimento, ma per l’ambiente» dice Razor. E non si riferisce solo all’“hostile environment”. Pensa all’amicizia che la guerra crea, a quella che in Australia chiamano “mateship”, la fratellanza, da mate «che non è solo un amico, è uno a cui affidi la vita». Come scrisse Hemingway, la guerra è male, ma c’è qualcosa nella guerra che, oltre al peggio, tira fuori anche il meglio degli uomini.
Razor s’inserisce in una cultura anch’essa deniable, negata, dichiarata falsa, scorretta. Quella analizzato dal filosofo James Hillman in Un terribile amore per la guerra, dove, frantumando la retorica politicamente corretta, ci spinge dentro “lo stato marziale dell’anima”. E’ quella raccontato da Sebastian Junger in War, cronaca e riflessione della sua esperienza da embedded in Afghanistan. Da quell’esperienza Junger e il fotografo Tim Hetherington (ucciso nel 2011 in Libia) hanno anche realizzato il documentario Restrepo. Libro e documentario sono una meditazione sulla guerra come condizione senza tempo dell’uomo. La guerra è ciò che Junger definisce “la difesa della tribù”, un istinto ancestrale. “La difesa del gruppo può rivelarsi così istintiva, può dare una tale dipendenza, che diviene la ragione stessa per cui il gruppo esiste…I ragazzi non combattono per la libertà o per patriottismo. Combattono perché sanno che possono essere uccisi”. Istinto che riappare nel saggio What It Is Like to Go to War di Karl Marlantes, che ha combattuto in Vietnam e ha già raccontato la sua esperienza in un romanzo divenuto bestseller: Matterhorn (qui in una recensione di Sebastian Junger).
Ma queste sono considerazioni che verranno dopo, quando cercherai di affermare le negazioni, esorcizzare le paure, sciogliere i dubbi. «Chi sono i buoni e chi sono i cattivi?» è la domanda che Razor ripete spesso e ti contagia.
Ascoltando Razor, d’un tratto, come il narratore del libro di Maugham, prendi le distanze, sei messo di fronte alle differenze. Come quando, indicando tante foto nel suo libro, Razor ripete: «Lui è morto, lui è morto, lui è morto, lui è morto…lui è morto…». Poche le morti per malattia. Un suicidio.
Quel filo di rasoio s’interseca sottilmente con molti altri, diventa una ragnatela tagliente. E senti il bisbiglio registrato del Colonnello Kurtz di Apocalypse Now. “Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere”.
Quel senso d’angoscia si scioglie a casa di Razor, nel nord di Phuket, in un gruppo di villette circondate da un piccolo giardino ombreggiato dagli alberi che sembra un quartiere di una cittadina dell’outback australiano. Respiri un’atmosfera quieta, mangiando un mango fresco, bevendo un succo di frutta preparato da una sorridente Nen, finalmente serena. La presenza di Razor l’avverti solo nella stanzetta dove lavora e conserva i suoi cimeli. Uno dei più preziosi è l’amaca di un soldato vietcong, ripiegata con cura assieme a molte bandiere. Emanano un leggero odore di naftalina.

Nella sezione Storie pubblico il capitolo introduttivo di “Razor’s Edge”. Ringrazio “Razor” per la concessione (e permettermi di chiamarlo così). Già da questa introduzione si capisce che il libro si presta a diverse chiavi di lettura: da parte del pubblico “normale” oppure degli addetti ai lavori. E’ una storia che può rivelarsi sgradevole, a tratti oscura. Come molte altre parti del libro. Ma è autentica.
Rovine e fantasmi della dolce vita khmer
13/02/12 05:16
«In certe vecchie case è meglio non entrare: ci sono i fantasmi». Così dice un colto e raffinato francese che studia le rovine delle ville di Kep, un villaggio sulla costa cambogiana, chiuso tra colline coperte da foresta, spiagge orlate di palme e paludi…Leggi nelle Storie (foto di Andrea Pistolesi).