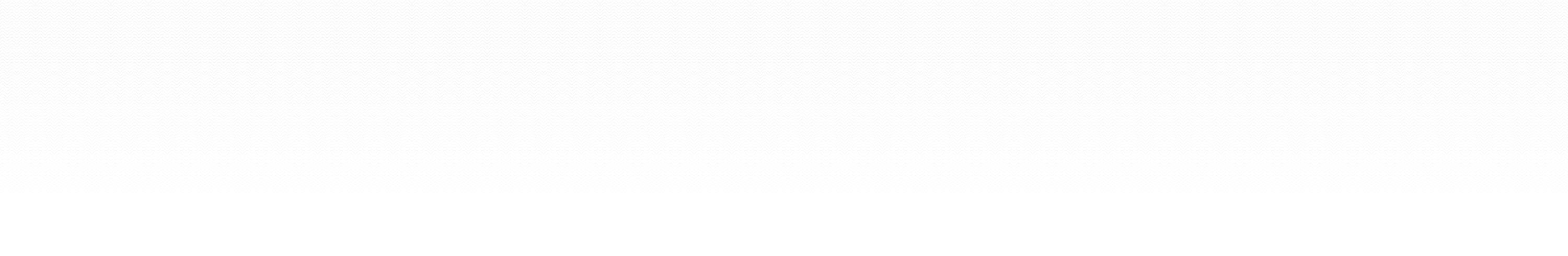Una storia che non finisce mai
23/05/15 11:33 Archiviato in: Le Storie

Articolo scritto nel 2009 per Il Foglio. Foto di Andrea Pistolesi, dal reportage Rohingya refugees in Bangladesh
Cox Bazar, Bangladesh. Saugida ha venduto il figlio più piccolo, due mesi, per 5000 taka, 57 euro. Con quei soldi, lei e gli altri due figli sono riusciti a sopravvivere per sei mesi. Il marito faceva il pescatore, è morto in mare qualche anno fa. Morjia, 25 anni, ha venduto i suoi capelli per 500 taka. Il marito è malato. Lo ha fatto perché stavano morendo di fame. Scosta il velo che le copre il capo e mostra la testa rasata. Poi indica i fianchi per far vedere sin dove arrivavano i capelli. Per la stessa cifra, 500 taka, poco meno di sei euro, Amina, 25 anni, ha venduto la figlia di 23 giorni. Si è sposata cinque anni fa e poco dopo il marito se n’è andato a cercare lavoro. Guarda i figli che tiene per mano: no, non li venderebbe. In questo momento.
Sono storie comuni tra le donne degli oltre 250.000 rifugiati Rohingya che vivono nella regione di Cox Bazar, nel sud del Bangladesh.
I Rohingya sono gli “unwanted”, gli indesiderati del sud-est asiatico. Vivono in un ciclo di povertà, repressione, fuga, cattura e schiavitù. Sono un gruppo etnico, circa 800.000 persone, di religione musulmana sunnita, stanziati nel nord dell’Arakan, uno stato della Birmania (rinominato Rakhine) sul Golfo del Bengala. Etnicamente e culturalmente sono assimilabili ai bengalesi di Chittagong, da cui sono separati dal corso del fiume Naf. Per questa differenza in Birmania sono discriminati e perseguitati più di chiunque altro. Non sono riconosciuti come etnia e sono considerati “immigrati illegali”. Non hanno diritto di cittadinanza né documenti, non possono spostarsi dal loro villaggio senza permesso e per averlo devono pagare. Sono alla totale mercé di qualunque funzionario locale, che può disporre delle loro case e delle loro vite. Negli ultimi tempi sono impiegati come schiavi nella costruzione di una strada che attraversa l’Arakan per facilitare il traffico sempre più intenso tra la Cina e il Golfo del Bengala, il suo sbocco strategico sull’Oceano Indiano.
In nome del mahan lumyogyi naingnngan, di una nazione monolitica, una specie di reich birmano, per evitare che prolifichino, il governo etnocratico dell’SPDC, lo State Peace and Development Council, la giunta militare, ha imposto ai Rohingya una complica procedura per richiedere il permesso di sposarsi. Che pagano cifre per loro enormi: da 50.000 a 200.000 kyatt (da 600 a 2400 euro).
«Brutti come orchi» li ha testualmente definiti il generale Ye Myint Aung, console del Myanmar (come la giunta ha ribattezzato la Birmania) a Hong Kong, per dimostrare che non possono far parte della sua razza eletta, dalla carnagione «chiara e delicata» come la sua, in contrasto con la pelle «bruno scuro» dei Rohingya.
«Per i Rohingya la Birmania è un vero inferno. La loro unica alternativa è fuggire in Bangladesh. Per quanto possano vivere da disperati, qui almeno possono farlo» dice un attivista politico Rohingya, uno dei pochi, che il Foglio ha incontrato a Cox Bazar.
«Per i Rohingya l’unica strategia di sopravvivenza è la fuga» conferma Raymond Hall, funzionario dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) a Bangkok.
La fuga comincia attraversando il corso del Naf, cercando di sfuggire agli uomini del Nasaka, la guardia di frontiera birmana. «Appena vedono qualcuno dalla pelle scura avvicinarsi al fiume gli prendono tutto e stuprano le donne» racconta Jalal, un rifugiato.
Circa 28.000, i più fortunati, quelli fuggiti dalla Birmania quasi vent’anni fa, sono accolti nei campi rifugiati ufficiali sotto il controllo dell’UNHCR. Ogni due settimane ricevono una razione di cibo, due volte al giorno per un’ora viene erogata acqua, hanno una minima assistenza medica, scuole elementari. Nel campo di Ukhiya c’è addirittura un’officina per la riparazione dei risciò. Poi c’è il campo non ufficiale – anzi, il “sito”, com’è burocraticamente definito – di Leda. E’ stato allestito otto mesi fa e accoglie circa 15.000 persone che prima vivevano in condizioni subumane ai margini della strada e sulle rive del Naf. Grazie ai finanziamenti della Comunità Europea e al lavoro di alcune ONG adesso sono passate alla dimensione umana. Tutti gli altri Rohingya sopravvivono e muoiono negli altri “siti” dell’area. Quasi per una perversa legge del contrappasso, però, quelli nei campi ufficiali non possono trovare lavoro fuori, perché in tal caso sarebbero dichiarati illegali. Gli altri, in quanto già illegali, possono farlo. Come conducenti di ciclo-risciò, nella saline, pescatori. Il guadagno medio è di 100 taka il giorno, un euro e 16 centesimi. Quelli davvero fortunati sono riusciti a emigrare nei paesi del Golfo Persico dopo aver comprato un passaporto falso. Da là riescono addirittura a mandare soldi a casa grazie al sistema hundi, termine bengali che indica il trasferimento illegale di valuta.
Saugida e Amina, le donne che hanno venduto i figli, vivono nel posto peggiore di tutti, il campo di Kutupalong, “un putrido inferno di speranze perdute e inumano squallore” come lo ha definito un reporter del New York Times, tra capanne di fango e bambù. Durante la stagione delle piogge quei rifugi si sciolgono, ingrossando i canali di scolo dove confluiscono i rifiuti e le deiezioni di oltre 12.000 persone. Il minimo incidente può essere mortale: un uomo che si è ferito raccogliendo legna è seduto in terra mentre una donna gli massaggia la gamba. Si sente la febbre solo a passargli accanto.
In queste condizioni, ai Rohingya non resta altro che riprendere la fuga. Cercano di raggiungere la Malaysia, lo stato islamico che nei loro sogni si è trasformato in una terra promessa. «Sono convinti che Allah li proteggerà» commenta tristemente l’attivista di Cox Bazar.
Tra dicembre e marzo, quando il monsone invernale porta bel tempo e placa il Mar delle Andamane, i Rohingya s’imbarcano su battelli sgangherati al largo dei 120 chilometri di spiaggia tra Teknaf, all’estremo sud del Bangladesh, e Cox Bazar. Li dovrebbero condurre in Thailandia, dove la loro odissea prosegue via terra sino al confine malesiano. Molti di loro scompaiono in mare, muoiono di fame, di sete, divorati dagli squali.
Nei mesi scorsi, durante l’esodo di questa stagione, la marina thailandese è stata accusata di aver ricacciato in mare un migliaio di boat people Rohingya, abbandonandoli al loro destino con due sacchi di riso e due galloni d’acqua per barca. Di cinquecento di loro non si hanno più notizie. Altri sono detenuti in attesa d’essere rimpatriati.
Per far sì che la storia dei Rohingya superasse i confini del sud-est asiatico c’è voluto l’intervento di Angelina Jolie. In visita ad altri campi profughi in Thailandia come “goodwill ambassador” dell’UNHCR, ha espresso preoccupazione per la sorte dei Rohingya, invitando il governo thai ad accogliere questi nuovi boat people.
Secondo alcuni osservatori la Thailandia vuole evitare che le sue coste siano invase da flussi sempre maggiori di profughi dalla Birmania e dal Bangladesh. Alcuni ufficiali thai, inoltre, hanno manifestato il timore che i Rohingya possano essere reclutati dai movimenti integralisti del sud, che hanno dichiarato una guerra del terrore per creare uno stato islamico indipendente. In realtà, secondo molti esperti delle organizzazioni umanitarie, quest’ultima ipotesi sembra improbabile. Come sostiene un osservatore locale, una volta in Thailandia, infatti, i Rohingya sono presi in consegna da trafficanti di esseri umani che spesso godono dell’appoggio proprio dei militari locali. Se questi credessero davvero che sono potenziali terroristi non li farebbero passare in Malaysia, da dove possono infiltrarsi in Thailandia ancor più facilmente.
«I Rohingya sono tra le vittime predestinate dei trafficanti di esseri umani» ha confermato Kitty McKinsey, portavoce dell’UNHCR nel corso della conferenza stampa in cui è stato presentato il “Global Report on Trafficking in Persons” dello United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC). Secondo gli analisti, i trafficanti hanno intessuto una vera e propria ragnatela che comprende campi sperduti nelle foreste della Thailandia sudorientale, dai quali i Rohingya sono smistati ai posti di lavoro nella Thailandia stessa e quindi in Malaysia o in Indonesia. Per essere intrappolati in questa rete i Rohingya accettano di pagare ai broker, gli intermediari, i dalal, come li chiamano in bengali, somme variabili tra i 20 e i 25.000 taka (dai 230 ai 290 euro), che verranno corrisposti detraendoli dai loro compensi. Ma quando partono non sanno che cosa andranno a fare né a che prezzo. Non sanno che quella cifra è solo per la prima tratta del viaggio, sino in Thailandia. Non sanno che nella maggior parte dei casi non saranno mai in condizioni di saldare il conto. Non sanno di essersi venduti.
Le storie che si raccontano nei campi Rohingya concordano in pieno con questi dati. In un caso la coincidenza è sconvolgente. Secondo il rapporto dell’UNODC, infatti, le donne sono proporzionalmente le più coinvolte nel traffico di esseri umani. Come trafficanti. E sono proprio le storie come quella di Saugida o Amina a confermarlo. In entrambi i casi è stata una donna a convincerle a vendere il proprio figlio, assicurando che gli avrebbero garantito un futuro migliore. La probabilità che sia stato adottato è minima: la maggior parte dei bambini sono venduti ai trafficanti d’organi, oppure ai pedofili, agli organizzatori di corse dei cammelli in Arabia Saudita per farne dei fantini, alle fabbriche per la lavorazione del pesce o a quelle di tappeti in Pakistan. Le loro piccole mani sono perfette per pulire i gamberi o intrecciare i tessuti.
Ed è stata una donna a tagliare i capelli di Amina. Di questi, almeno, si sa dove sono finiti: sono stati esportati in Birmania e là venduti in Cina per essere trasformati in parrucche o extension.
Che i Rohingya siano “voluti” solo dai trafficanti di esseri umani è confermato dalle decine di storie raccolte da il Foglio. Sono storie che non riesci a credere: pensi se le inventino per un’elemosina. Invece tendono la mano per darti una foto, un bigliettino con un nome e un indecifrabile indirizzo. Per loro sono messaggi in bottiglia.
E’ la storia di Dildar, 25 anni, tre figli di quattro, due e un anno. Abita in una baracca del “sito” di Leda. E’ arrivata in Bangladesh quattro anni fa, col marito Ashan. Si erano sposati di nascosto in Birmania, con la benedizione di un imam locale, ma non potevano convivere senza il permesso delle autorità locali e non avevano i soldi per pagarlo. Se li avessero scoperti, rischiavano di finire in prigione. Così, una notte hanno attraversato il Naf e si sono stabiliti sul campo che c’era sull’altra riva del fiume. Nel novembre scorso il marito ha deciso di tentare la fortuna in Malesia. Un uomo, racconta Dildar, gli ha detto che là avrebbe trovato un lavoro e con i soldi avrebbe pagato il viaggio. Lei ha dato il suo consenso perché pensava che così potevano sopravvivere. Ashan si è imbarcato la notte del 9 dicembre assieme ad altre 130 persone su una barca da pesca bangladeshi. Adesso Dilder sopravvive con le elemosine che raccolgono i figli.
E’ la storia di Norna, 26 anni, sposa a 14, con sei figli. Anche lei dipende dalle loro elemosine e anche suo marito è partito per la Malaysia in dicembre.
E’ la storia di Jahur, 74 anni. Lui è arrivato qua tre anni fa con la moglie e gli 11 figli. Era un contadino, viveva quasi bene nel suo villaggio in Birmania. Ma un giorno le autorità locali gli hanno confiscato la casa e il terreno. Gli hanno solo detto: “vai via di casa, ci serve”. Nel dicembre scorso il figlio ventenne è partito per cercare fortuna in Malaysia. Ogni tanto il vecchio Jahur pensa di tornare in Birmania, poi ci rinuncia perché ha paura e perché ormai i figli sono in età di matrimonio e là non potrebbero sposarsi.
Nessuno di loro ha più avuto notizie. Le uniche informazioni sulla sorte di tutti quegli uomini sono i vaghi messaggi portati da qualche marinaio bangladeshi. Dicono che le barche sono state fermate dalla marina indonesiana o da quella indiana mentre vagavano nell’Oceano Indiano. Per quanto confusi, questi racconti corrispondono ai rapporti ufficiali degli ultimi mesi: molte delle barche che portavano i Rohingya, dopo essere state respinte in mare dalla marina thailandese, hanno fatto rotta per gli arcipelaghi indiani delle Andamane e delle Nicobare o per la provincia indonesiana di Banda Aceh, a Sumatra. I più sfortunati sono stati bloccati prima, al largo delle coste dell’Arakan, dalle navi birmane. «Loro sono tornati all’inferno» dice Jamal, un bangladeshi di Cox Bazar che da anni segue le vicende dei Rohingyas. Sono destinati ad almeno sette anni di prigione o ai lavori forzati.
«E’ una vecchia, tragica storia» commenta Jamal. Come tutti i bangladeshi, da un lato compatisce i Rohingya, sente una sorta di fratellanza etnica e religiosa. Dall’altro è cosciente del fatto che il Bangladesh non può accoglierli, è costretto a porre freno alla loro fuga. «Se accettasse di aprire nuovi campi ufficiali arriverebbero altri Rohingya a popolare i siti abbandonati. E qui siamo già in troppi per troppo poco lavoro. Sarebbe una guerra tra poveri».
Più duro un funzionario pubblico bangladeshi. «I Rohingya preferiscono stare qui e non avere vita piuttosto che tornare nel loro paese e lottare».
Le stesse contraddizioni si avvertono in Thailandia, che vanta una tradizione buddhista di paese “compassionevole”, ha accolto e accoglie centinaia di migliaia di rifugiati. Ma che ora, nella prospettiva di una crisi economica globale, teme di essere letteralmente “invasa”. Anche per questo le critiche per il rifiuto di accogliere i rifugiati Rohingya e le violenze contro di loro sono state interpretate in chiave “occidentalista”: l’ennesimo segno dell’arroganza dei paesi più ricchi, che giudicano secondo il loro metro di giudizio, senza assumersi alcuna responsabilità.
«Gli inglesi hanno occupato la Birmania, quando gli ha fatto comodo. Dovrebbero tornarci, se vogliono mettere a posto le cose» ha dichiarato con la sua abituale rudezza il colonnello Manas Kongpan, responsabile regionale dell’Internal Security Operations Command, in un seminario sui Rohingya svolto alla Chulalongkorn University di Bangkok pochi giorni fa.
Nella stessa occasione il rappresentante regionale dell’UNHCR ha ammesso che la soluzione a lungo termine del problema dei Rohingya può essere definita solo in Birmania. In caso contrario, questo potrebbe divenire, oltre che un problema umanitario, un problema per tutta l’area. Per prevenire tale eventualità il governo Thailandese e quello indonesiano hanno indetto un meeting internazionale (che dovrebbe svolgersi a fine marzo).
Nel frattempo in Birmania sembra che la giunta stia seguendo la sua road map per un passaggio a una forma di dittatura morbida, o democrazia limitata, che sembra divenuta il modello dell’area. Ne è segno la liberazione di qualche decina di detenuti politici. In compenso il Segretario di Stato Americano Hillary Clinton, dopo il suo viaggio in Cina, ha dichiarato che l’amministrazione del presidente Obama sta pensando di offrire nuove chance al governo birmano.
Mentre accadevano tutte queste grandi manovre, nel campo di Kutupalong hanno sepolto Selina Begum. Aveva 63 anni. Per la gente di là è morta di vecchiaia.